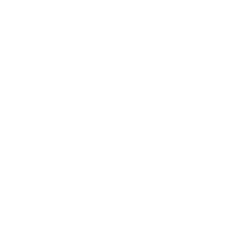Privacy, termine dell’inglese, traducibile in italiano con riservatezza o privatezza, indica, nel lessico giuridico-legale, il diritto alla riservatezza della vita privata di una persona.
Il diritto a non essere soggetto a violazioni non autorizzate della parte più privata della propria esistenza da parte del governo, delle società o degli individui fa parte delle leggi sulla privacy di molti Stati del mondo e, in alcuni casi, delle costituzioni.
Evoluzione storica del concetto
Il concetto si sviluppa fin dell’Antica Grecia, quando, in una serie di trattati filosofici si inizia a far riferimento ad un “senso di riservatezza”. Aristotele, nella sua Politica, distingue tra Polis, sfera pubblica dell’individuo, correlata alle attività cittadine, ed Oikos, sfera privata, associata alla vita domestica. Viene così stabilito l’ambito personale, distinto da pubblico e politico. Per gli antichi greci il coinvolgimento da parte degli uomini nella vita pubblica era di fondamentale importanza; parallelamente, però, riconoscevano al singolo la necessità di una sfera propria e riservata, da intendersi come luogo in cui occuparsi dei propri bisogni. L’affermarsi di città-stato significa per l’uomo ricevere una personale vita activa, marcando il discrimine tra ciò che è proprio contro ciò che è comune. La vita privata è rispettata in quanto considerata elemento necessario a far scaturire uno stimolo d’interesse cittadino. Ogni uomo che ha proprietà nella città sarà interessato al suo corretto funzionamento.
Durante l’età feudale si espande l’ideale di libertà personale e, successivamente, grazie allo Stato assoluto, ciò che separa privato e pubblico viene delineato al punto da originare la sfera del privato. Riforme religiose e diffusione dell’alfabetizzazione sono tra gli elementi che condizionano fortemente la società occidentale del XVI e XVII secolo. Tali elementi portano proprio ad un mutamento radicale della mentalità sociale, diffondendo un nuovo costume d’appartenenza.
La connotazione odierna di privacy, però, si afferma proprio a seguito della caduta del feudalesimo. XVIII e XIX rappresenterebbero un’era prolifica per il diritto. Nel 1890, due giuristi statunitensi, Louis Brandeis e Samuel Warren, pubblicarono “The Right of Privacy”[6] sulla Harward Law Review, prima monografia giuridica a riconoscere “the right to be let alone”, “diritto ad essere lasciato da solo”. Esprimendo in queste parole il desiderio di una propria ed inviolabile intimità[7][8].
Ciononostante, le prime accezioni del termine si riferiscono ad una casistica tendente al negativo, la libertà ottenuta con il concetto di privacy non è associata ad una possibilità “di”, quanto ad una liberazione “da” un qualcosa/qualcuno. Il periodo storico è quello della rivoluzione industriale, ciò è quindi da intendere non in ottica universale, quanto riferito al ceto borghese. È già qui evincibile quanto il concetto di privacy si riscopra in ogni contesto storico, dovendosi interfacciare con una serie di nuove necessità personali che in esso si affermano. Il sancire un’impossibilità di ingresso in uno spazio altrui, come sottolineato da Rodotà, funge da snodo culturale fondamentale nell’affermazione della privacy odierna.
In ottica europea si ha una prima formazione del concetto di privato tra XVIII e XIX secolo. In Germania origina la discussione su una serie di possibilità individuali originanti dal “diritto naturale”, elemento d’influenza della filosofia giuridica tedesca.
Nel 1954 una sentenza del Bundesgerichtshof determina, per la prima volta, un basilare diritto alla personalità.
La discussione d’origine germanica si estese così per il continente, fintanto che nel 1909, in Francia, si giunge alla legittimazione dei diritti della personalità.
Parallelamente, nel Bel paese, il concetto viene portato avanti da Adolfo Ravà, docente di Filosofia del diritto. I punti sollevati da Ravà, seppur paralleli al pensiero tedesco, hanno origine indipendente. Analizzando il Tractatus de potestate in seipsum di Baldassarre Gomez de Amescua, giurista spagnolo del XVI secolo, ne coniuga un “diritto sulla propria persona”, che esclude però una lunga serie d’elementi per noi correlati, quali: diritto d’autore, sul nome, sul marchio. Successivamente sarà sempre Ravà a determinare per analogia legis il “diritto alla riservatezza”.
I primi casi di violazione si presentano tra gli anni ’50 e ’60. Caso particolarmente significativo è la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nel 1963. Il settimanale italiano “Tempo” ottenne attenzione popolare diffondendo una serie di particolari inerenti alla vita intima di Claretta Petacci, amante di Benito Mussolini. A seguito della constatazione ne scaturì una denuncia da parte della sorella minore della Petacci, Miria di San Servolo.
Nel 1975 anche il Supremo Collegio italiano si adeguò alle controparti europee affermando l’esistenza di un diritto alla riservatezza. Il tutto scaturì a seguito di controversie con Soraya Esfandiari che fu fotografata, nelle proprie mura domestiche, in atteggiamenti intimi con un uomo.
Tornando all’ottica comunitaria, una serie di provvedimenti fu ribadita: direttive 95/46/CE, 97/66/CE, e 2002/58/CE.
In Italia, consecutivamente alla 95/46/CE si ha l’istituzione di una figura di garante per la protezione dei dati personali. Seguì l’emanazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, il quale introdusse nell’ordinamento italiano un autonomo diritto alla protezione dei dati personali, indipendente rispetto alla tutela della sfera intima dell’individuo. L’estensione europea di questa visione entra in vigore il 7 dicembre 2000, con l’art. 8, comma I della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, detta anche Carta di Nizza, che fa esplicito riferimento al diritto alla protezione dei dati personali.
Nel 2016 esce il Regolamento generale sulla protezione dei dati che sostituisce la vecchia direttiva, la sua attuazione è avvenuta a distanza di due anni, quindi a partire dal 25 maggio 2018. È composto da 99 articoli e 173 considerando, questi ultimi con solo valore interpretativo. Trattandosi di un regolamento, non necessita di recepimento da parte degli Stati dell’Unione ed è attuato allo stesso modo in tutti gli Stati dell’Unione senza margini di libertà nell’adattamento, tranne per le parti per le quali si prevede espressamente delle possibilità di deroga.