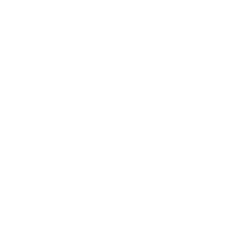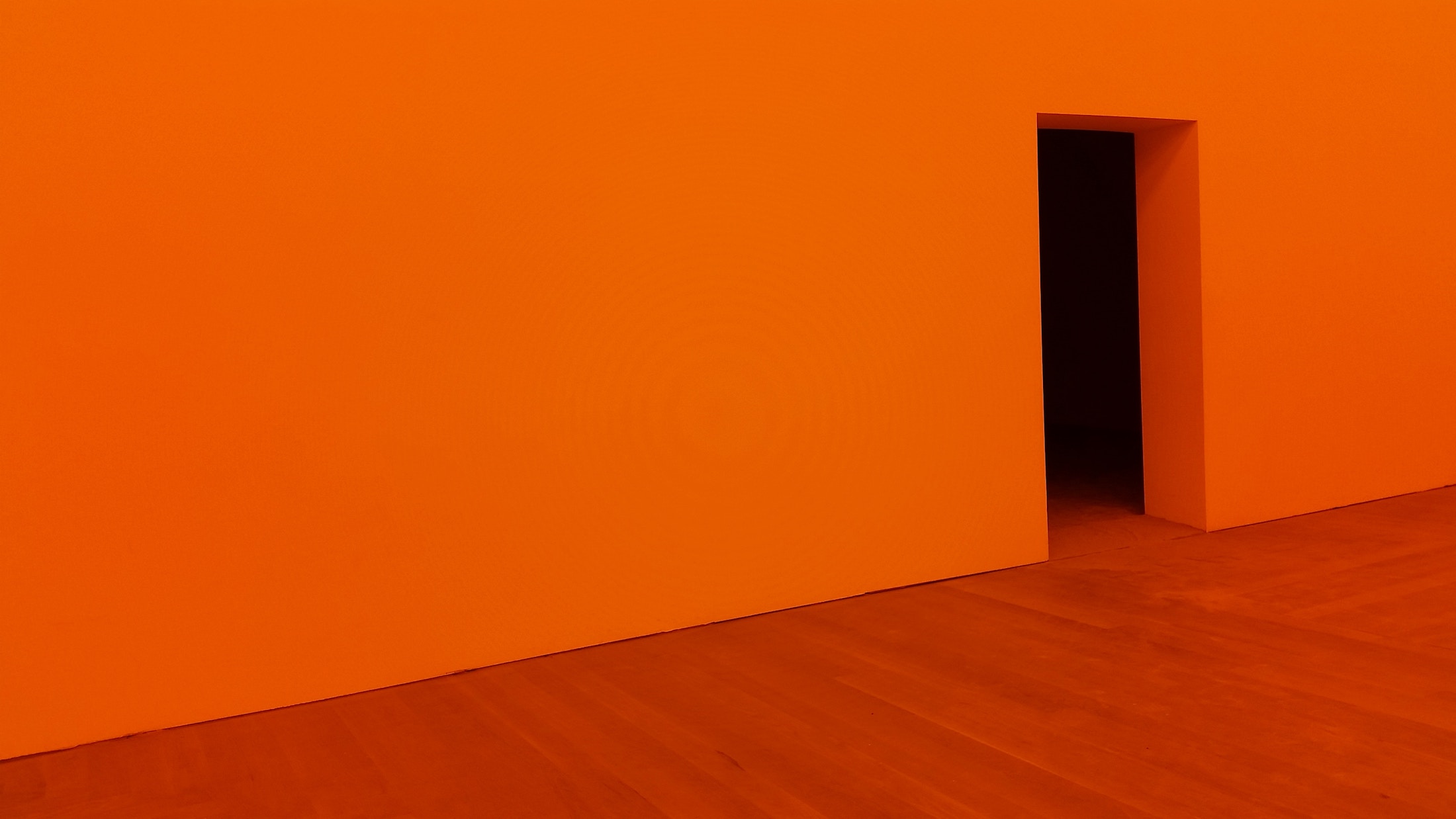I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
La società della Tecnica e dell’Informazione
La tecnologia ha assunto negli ultimi decenni una rilevanza crescente e significativa in tutti i contesti socio-economici.
La diffusione delle tecnologie informatiche, che costituiscono il cuore della società dell’informazione, la rivoluzione tecnologica e sociale degli ultimi anni può essere ricondotta al passaggio dalla società industriale alla società dell’informazione.
L’informatizzazione ha condotto alla formazione di un nuovo modello: la società dell’informazione.
Le tecnologie informatiche e di telecomunicazione assumono un ruolo significativo nello sviluppo delle attività umane. È evidente che la rivoluzione digitale è indissolubilmente connessa con l’evoluzione della società dell’informazione.
La rivoluzione digitale sancisce il passaggio dalla tecnologia meccanica ed
elettronica analogica a quella elettronica digitale, rivoluzione che ha interessato i Paesi industrializzati già a partire dalla metà del secolo scorso.
La rivoluzione digitale procede parallelamente alla cosiddetta rivoluzione informatica, intesa quale processo di cambiamento apportato dalle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, in ragione soprattutto dello sviluppo del World Wide Web.
Dreyfus, docente all’Università di Harvard, ha coniato nel 1962 il termine informatica dall’spressione francese information automatique, per indicare la gestione automatica di dati e in formazioni mediante calcolatore. Dagli anni Ottanta del secolo scorso, l’informatica ha trovato larga diffusione nella società.
La società dell’informazione è caratterizzata dalla gestione e dalla ricerca automatizzata delle informazioni, e permea tutte le attività umane. La trasformazione connessa all’elaborazione automatica delle informazioni non si limita infatti alle attività produttive e amministrative,
poiché l’informatica crea il ciberspazio, il mondo virtuale delle reti informatiche.
L’informatica ha conquistato, per certi versi, anche lo spazio fisico attribuendo agli oggetti la capacità di elaborare e comunicare.
Si parla dunque di Internet of Things (internet delle cose) per indicare l’estensione di Internet anche al mondo degli oggetti. Internet of Things descrive un sistema in cui internet è collegato al mondo fisico mediante sensori che consentono alle applicazioni di far “comunicare” gli oggetti. L’identificazione di ciascun oggetto avviene tramite minuscoli transponder a radiofrequenza in essi inseriti, oppure mediante codici a barre o codici grafici bidimensionali impressi sull’oggetto. Le applicazioni riguardano, dunque, la gestione di beni di consumo (durante la produzione, l’immagazzinamento, la distribuzione, la vendita o l’assistenza postvendita), o anche il tracciamento di oggetti.
Comprendere come la sfera giuridica sia stata coinvolta e interessata dalle dinamiche connesse allo sviluppo tecnologico è un approfondimento avvincente.
L’utilizzo di strumenti informatici non ha comportato esclusivamente questioni di carattere tecnico, investendo numerosi ambiti della riflessione giuridica.
Il mutamento della realtà conseguente all’innovazione scientifica e tecnologica investe immediatamente il diritto, tanto che alcune vicende prima ritenute giuridicamente irrilevanti interessano ora il giurista, così come altre, collocate tradizionalmente in una sfera di rilevanza pubblicistica, entrano invece nell’orbita dell’autonomia privata. Fino a poco tempo fa, l’intervento del sistema giuridico si è limitato alla risoluzione di controversie di non eccessiva complessità sociale. Rispetto a esse, è stato sufficiente rimodulare le interpretazioni delle norme esistenti in funzione delle esigenze via via sollevate dal progresso scientifico. La diffusione delle tecnologie informatiche ha richiesto ai legislatori l’emanazione di norme ad hoc, in grado di disciplinare le nuove istanze connesse all’implementazione tecnologica. Il rapporto tra tecnologia e diritto si è configurato in termini complessi sin dall’inizio: innanzitutto, dal punto di vista definitorio, vi è la tradizionale bipartizione nel rapporto tra l’informatica e il diritto, che si risolve nella suddivisione in informatica giuridica e diritto dell’informatica.
Il diritto dell’informatica esamina i problemi giuridici connessi all’utilizzo delle tecnologie di comunicazione e dell’informatica, e gli effetti riconducibili ai comportamenti posti in essere utilizzando le tecnologie nella vita sociale.
Si concretizza nello studio delle vicende giuridiche nel contesto delle nuove tecnologie soprattutto telematiche, e in riferimento alle modalità con cui il progresso tecnologico incide sulla tutela dei dati personali, sulla tutela dei diritti della personalità, sulla conclusione dei contratti del commercio elettronico.
Le aree di studio possono essere così riassunte:
• Tutela dei dati-privacy
• Proprietà intellettuale informatica
• Documenti digitali
• Commercio elettronico (e-commerce)
• Proprietà intellettuale informatica
• Documenti digitali
• Governo elettronico: e-governance
• Reati informatici
La rivoluzione connessa alla società dell’informazione incide in maniera significativa sulla riflessione giuridica. L’attività giuridica è oggetto dell’informatizzazione e non esclusivamente in relazione all’acquisizione di nuovi strumenti di lavoro. Il giurista deve operare in stretta correlazione con gli strumenti informatici e deve contestualmente operare negli ambienti virtuali creati dalla tecnologia.
Su questi presupposti si concretizza la dottrina dell’ informatica giuridica.
L’informatica giuridica è la disciplina che studia l’informatica applicata al diritto, concetrandosi sugli aspetti giuridici della rivoluzione tecnologica, economica e sociale connessi all’informatica.
Con l’espressione informatica giuridica si fa generalmente riferimento al ruolo che gli strumenti informatici rivestono in relazione a molti settori del diritto: dalla gestione di database al processo telematico fino alla possibilità di tradurre a livello di algoritmo schemi di ragionamento tipici dell’argomentazione giuridica (le sentenze).
In alcuni ambiti, le questioni del diritto dell’informatica sono connesse con quelle dell’informatica del diritto e ciò avviene quando il legislatore regola l’uso dell’informatica in alcune attività giuridiche. Si pensi al processo civile telematico, materia in cui il diritto dell’informatica regola e individua le soluzioni organizzative e tecnologiche, oppure al tema dell’informatica nella pubblica amministrazione.
Le vicende che presentano tale duplice profilo di rilevanza sono: il documento informatico, la firma elettronica la circolazione e la tutale degli atti e dei dati informatici.
L’informatizzazione ha avuto un significativo impatto sulla vita sociale, contribuendo da una parte a determinare nuovi rischi e, dall’altra, ad introdurre nuove opportunità per l’economia, la politica e la vita sociale.
Sotto un altro aspetto, l’informatizzazione modifica il lavoro del giurista che si avvale sempre più di frequente degli strumenti informatici.
Al di là delle sia pur necessarie e utili questioni definitorie, è interessante comprendere come l’irrompere della tecnologia, soprattutto informatica, abbia trasformato la prospettiva della riflessione giuridica.
Il tema di analisi prende inizio dai rischi connessi all’impatto delle tecnologie sulla tutela della persona e dei diritti della personalità.

Nel prossimo articolo parleremo delle nuove tecnologie e interessi tutelati, buona lettura.